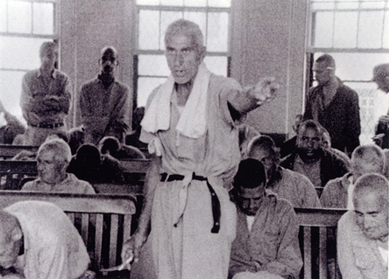
Quarant’anni di carriera registica e trentasei pellicole girate. Ospedali, tribunali, quartieri popolari e uffici dei
servizi sociali sono solo alcuni esempi dei microcosmi presi in analisi da quello che è considerato uno dei più grandi
documentaristi viventi. Da
Titicut Folies del 1967, sul manicomio criminale di Bridgewater, a
State
Legislature sulla burocratica pseudodemocrazia statunitense – l’ultimo lavoro presentato a Filmmaker 2007 – si snoda
una filmografia compatta negli intenti e nelle scelte stilistiche.
Al centro l’essere umano come animale sociale. L’individuo non è mai interessante per il suo essere portatore di una vicenda
privata significativa in sé e per sé perché unica, straordinaria o esemplare; il singolo acquista evidenza in quanto polo
di un’interazione con la collettività, in quanto parte del tutto. Nei documentari di Wiseman è assente l’eroe, il
personaggio principale che spesso costituisce l’ossatura di un’opera; ogni volto è strumento usato per costruire il
ritratto di un sistema complesso e comunitario, spesso identificato con un ambiente chiuso e circoscritto. Wiseman o della
claustrofilia: realizza infatti un cinema prevalentemente d’interni benché siano rintracciabili nel corpus delle sue opere
alcune eccezioni alla regola come Aspen (1990), dedicato a una località americana del turismo invernale, o
Sinai Field
Mission (1990) in cui le dune del deserto riempiono il quadro.
Armato di una macchina (quasi) sempre rigorosamente a mano, Wiseman ci guida alla scoperta di realtà altrimenti
inaccessibili o ci invita a guardare il quotidiano con occhi diversi (chi non ha esperienza di un centro commerciale?), ma
non ci prende per mano: mostra il più possibile di ciò che ha scelto di indagare – si spiega così la corposità temporale
della maggior parte dei suoi lavori – e lo fa dando voce ai molteplici punti di vista che si incontrano e si scontrano
sulla scena, in modo da lasciare lo spettatore libero di formulare un giudizio offrendogli tutto il tempo per riflettere.
Non propone soluzioni, non sviluppa film a tesi. È sempre valido e attuale l’assunto baziniano: mostrare e non dimostrare.

Il regista ricerca un rapporto di profonda comprensione con la realtà e lascia che essa sprigioni i suoi significati senza
apporre e imporre filtri ideologici. Tutto questo non significa però neutralità, la presenza dell’autore non si riduce
all’ondeggiare discreto del quadro. In fase di montaggio Wiseman demiurgo plasma il materiale umano, sociale, animale
(alcune pellicole come
Primate e
Zoo indagano il rapporto tra creature animali e umane) dando vita a una
realtà possibile, quella che è il frutto della personale interpretazione dell’autore, il quale le conferisce così
significato politico. Si può citare come caso esemplare il “materialismo” che innerva
The Store (1983). Gli
individui sono identificati con la merce che vendono o comprano, diventano essi stessi merce; gli oggetti dominano
audio-visivamente le inquadrature: mostrati dall’occhio della macchina mentre vengono palpati e accarezzati da centinaia
di mani (si potrebbe addirittura parlare di oggetto erotizzato) o ridotti a parole vomitate da centinaia di bocche, lunghe
liste che fanno riecheggiare nella nostra mente gli elenchi stilati da Georses Perec.
Le microsocietà di volta in volta indagate da Wiseman si configurano come riflesso della società americana, ma non solo.
Fotografando il contingente, il fatto in sé, Wiseman dà forma all’invisibile ossia alle istituzioni e alle categorie
astratte che caratterizzano il mondo occidentale, tutto ciò che per sua natura sarebbe irrappresentabile: il lussuoso
grande magazzino
Nieman Marcus di
The Store (1983) non è solo quel preciso, concreto, individuabile negozio,
ma è
il Negozio e ancora di più è il Commercio, il venduto e il vendibile. E ancora. L’ufficio dei Servizi Sociali
di New York in
Welfare è la trasposizione per immagini delle idee di Burocrazia e Povertà e trascende a simbolo
della solitudine umana. Dal fenomenico al noumenico, potremmo dire.
Il realismo appare però essere la vocazione primaria del cinema di Wiseman. Metodo di ripresa, taglio e lunghezza
dell’inquadrature, scelte nel campo del sonoro sono indirizzati ad ottenere il massimo effetto di realtà. Inquadrature
lunghe, spesso veri e propri piani sequenza, racchiudono singoli episodi, colti quasi per caso nella magmatica complessità

dei luoghi fotografati. Bandita la musica extradiegetica e proibito ogni commento
off, la colonna audio è composta
esclusivamente da suoni e rumori in presa diretta che restituiscono l’autentica acustica “multistrato” degli ambienti.
Wiseman rigetta anche l’uso dei cartelli, l’unica scritta sovrimpressa che compare nelle inquadrature iniziali dei suoi
lavori è quella che permette allo spettatore di capire dove lo porterà lo sguardo del regista.
Abbondano primi e primissimi piani, la macchina indugia però sui visi senza alcuno psicologismo: l’occhio che li guarda è
quasi quello dello scienziato che porta avanti il suo studio sull’oggetto che ha scelto di investigare e di cui le figure
umane sono la manifestazione tangibile.
Possiamo infatti definire i suoi film ricerche sul campo filmate. Il metodo Wiseman è lo stesso utilizzato dagli studiosi
che hanno fatto la storia dell’antropologia, da Ernesto De Martino a Marcel Griaule: una lunga preparazione pre-riprese
allo scopo di dilatare i tempi di riflessione e per far sì che la macchina da presa non venga percepita come elemento
disturbante capace di condizionare le azioni e gli atteggiamenti di chi è ripreso. Wiseman mira al “come se la cinepresa
non esistesse” per questo cerca di occultarsi il più possibile; a questo scopo, ad esempio, non usa l’intervista e anche
quando sembra che un individuo stia parlando con qualcuno posto al di là della macchina da presa, in realtà è sempre
un’illusione scenica che il regista gioca allo spettatore: il campo si allarga e scopriamo di essere nel mezzo di una
riunione dei responsabili delle vendite (
The Store) o di un incontro fra gli esponenti di un’associazione per il
recupero del quartiere-ghetto in cui vivono solo persone di colore (
Public Housing). Ovviamente più unici che rari
gli sguardi in macchina, una prescrizione che l’autore eredita direttamente dalla fiction. Appare infine coerente la scelta
di una troupe leggera, non invasiva, tipica del genere documentario: Wiseman come regista, (spesso) produttore, montatore
e fonico; un operatore (fino al 1978 William Brayne, da allora sempre e solo John Davey, secondo paio d’occhi dell’autore)
e uno o due assistenti.

“Per comprendere come funziona la società, bisogna guardare a tutti gli strati sociali e nella società americana uno degli
aspetti fondamentali è il concetto di classe”. Il Grande Tema del cinema di Wiseman è la rappresentazione del potere e la
sua profonda diseguale spartizione in un paese che ha costruito il suo
mythos sui concetti di libertà e democrazia.
La parola è il medium prediletto dall’autore per far comprendere allo spettatore i rapporti di forza fra gli individui
ripresi e ciò spiega la sua preminenza sull’azione: da una parte colui che parla per essere ascoltato e soprattutto
obbedito; dall’altra i discorsi destinati al vento di chi non ha diritti o il silenzio di chi può solo annuire.