
E’ difficile che in una sola stagione cinematografica vengano presentati due titoli piuttosto simili tra di loro, per
ambientazioni e personaggi: parliamo dell’ultimo film di Christopher Nolan,
The Prestige, e di
The Illusionist, di Neil Burger, appena uscito nelle sale italiane. In entrambi assistiamo alle vicende di trucchi,
maghi, inganni, belle assistenti (anche se non si può fare a meno di obiettare che Jessica Biel appare come una versione un
po’ sbiadita della Scarlett Johannson che si frappone tra i due prestigiatori in Nolan), teatri gremiti di pubblico
affascinato, impresari ed investigatori. Eppure, metterli a confronto cercando di assegnare più stellette (o pallini) a
l’uno o all’altro film è un’operazione non del tutto giusta e corretta: Nolan e Burger, due registi dalle carriere non
paragonabili (Burger è perlopiù sconosciuto) hanno intenzioni completamente diverse, e le perseguono con modalità diverse.
L’intrigo politico, il triangolo amoroso, l’illusionismo:
The Illusionist, condensa tre nuclei tematici fondamentali
della narrazione cinematografica, avvolgendoli di giallo in un classico plot poliziesco.
Il giovane Edward, figlio di un ebanista della Vienna del diciannovesimo secolo, si innamora di Sophie, giovane duchessa,
destinata a far parte della corte imperiale. Quasi in risposta alla privazione amorosa che subisce, il ragazzo scompare per
far ritorno a Vienna soltanto quindici anni più tardi, nei panni di Eisenheim l’Illusionista (Edward Norton). I suoi
trucchi destano i sospetti della corte di Leopoldo, principe ereditario ed ora promesso sposo a Sophie (Jessica Biel); egli
intuisce l’antico legame che lega il mago alla donna e, coadiuvato dall’ispettore capo della polizia Uhl (Paul Giamatti),
inizia a perseguitare l’attività di Esenheim, ritenuta una minaccia all’ordine costituito.

Potrebbe mai un film, che ha come protagonista un illusionista e i suoi espedienti, non basarsi interamente sulla
mistificazione delle apparenze? Certamente no.
The Illusionist inganna realmente lo spettatore sino alla risoluzione
finale, offrendo un intreccio fin troppo semplice, sebbene gestito in modo perfetto: troppo nitidi i contrasti tra buoni e
cattivi, troppo chiare le intenzioni di ciascun personaggio, troppo semplice la risoluzione del caso. Sino a giungere agli
ultimissimi minuti, in cui una brevissima e rapida sequenza dimostra l’esatto contrario, ovvero l’unica verità
dell’illusione, quella secondo cui nulla di quanto noi vediamo corrisponde a verità. La sottotraccia ha sia dei risvolti
politici che sottilmente metanarrativi, soprattutto considerando che i trucchi ideati da Eisenheim sono tutti trucchi di
tipo filmico, e l’intera narrazione degli eventi, scandita da apertura e chiusura di iridi, procede come se stessimo
osservando una lanterna magica o uno zootropio dal sapore pre-cinematografico. Il tutto è confermato dalla scelta
fotografica operata da Dick Pope (che ha ottenuto una nomination agli Oscar di quest’anno), che avvolge tutto di
colorazioni ocra e seppia proprio come se i personaggi animassero antiche fotografie. La sequenza finale è, infatti,
l’unica in cui i colori sono naturali e non giallastri, come prova visiva del fatto che quella, e soltanto quella,
corrisponde alla realtà dei fatti. Il ritmo asseconda quello mai concitato e teso del giallo tradizionale, gestito dalle
buone interpretazioni degli attori tra cui si distingue un ottimo Paul Giamatti, che si riconferma come attore versatile e
dotato di una spontanea simpatia. Impossibile non citare il meraviglioso contributo di Philip Glass, che puntella la
colonna sonora di suspense con magistrale discrezione.
The Illusionist non fa parte di quella categoria di film sui
prestigiatori (tra cui per l’appunto
The Prestige) che ruotano intorno alla ricerca di una spiegazione razionale dei
trucchi. Perturbante per il pubblico ammirato e pericolosa per l’infido principe, l’illusione resta quella che è, perfetta
nella sua ambiguità, come i fantasmi a cui Eisenheim dà, apparentemente, vita.
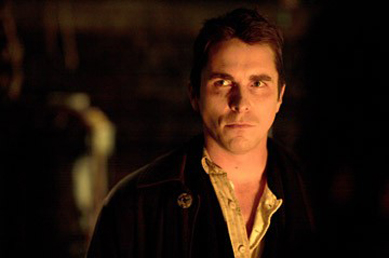
Il valore metacinematografico del film di Christopher Nolan, interpretato da Hugh Jackman, Christian Bale e Michael Caine,
è stato già analizzato (Barbara Aronica, febbraio 2007,
Zoom). Le vicende dei due antagonisti, un tempo amici
fidati, procedono parallelamente intrecciando presente e futuro e scrivendo una narrazione circolare (il punto in cui
iniziano gli eventi è lo stesso in cui finiscono). Mai come in questo caso è stato appropriato parlare di
mise en àbyme degli elementi utili alla decifrazione di un testo: sebbene anche stavolta il regista non nasconda
nessuna immagine allo spettatore, come era accaduto per il precedente
Memento, egli è mantenuto costantemente in
una sensazione di incertezza rispetto agli eventi narrati. La risoluzione finale dell’intreccio può essere al contempo ciò
che sembra e il suo opposto. Trattandosi delle vicende di due prestigiatori in competizione, assistiamo alla spiegazione
dei loro trucchi, oscillante tra razionalità scientifica e il soprannaturale. Ma nessuna delle loro esplicazioni sembrano
far tacere i dubbi sui loro esperimenti: ciò che viene mostrata, ricoperta da un’aura di definitezza soltanto apparente, è
al massimo un’ipotesi di razionalizzazione degli eventi. Al livello della sceneggiatura, il film non è privo del suo
finale; al livello della visione invece, le immagini restano avvolte nelle nebbie dell’incertezza (si tratta pur sempre di
illusionismo), come chiosa la citazione tratta dal film posta all’inizio del paragrafo. Nolan persegue nell’abbandono
della linearità, facendosi che le due linee narrative (l’una di Jackman, l’altra di Bale) prendano le mosse dalla lettura
di un testo: l’uno legge il diario di appunti dell’altro, in una rete di rimandi volti alla costruzione di un invisibile
split screen sovrastante l’intera struttura del racconto.
A scontrarsi, molto più che due dive e tre sex symbol maschili, sono quindi due diverse idee di racconto. Nolan utilizza
l’artificio della visione, di cui il cinema è per essenza una delle sue definizioni, strutturando l’inganno attraverso una
narrazione non lineare; Burger sceglie di ingannare attraverso i fatti, nella maniera più classica del noir e del
poliziesco, senza fare del suo film un esempio di metacinema o di film “autoformante”, ma comunque restituendo una buona
idea di cinema. Il fatto che due titoli così pericolosamente accostabili offrano due diverse idee di racconto dimostra che,
ancora una volta, quando il cinema recupera il suo antico carattere di fantasmagoria non delude mai, la primigenia matrice
di fabbrica dei sogni è, ancora e all’ennesima potenza, l’autentica natura della Settima Arte.